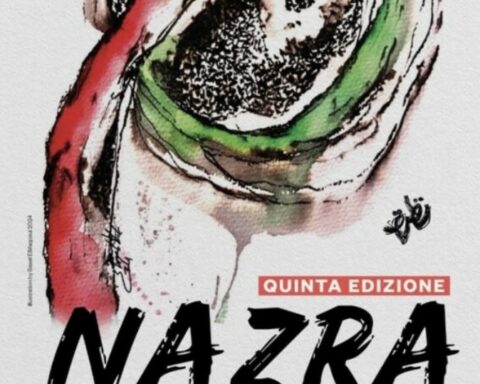Di solito non ci occupiamo di argomenti che non siano catanesi e siciliani o legati comunque alla Sicilia e di interesse siciliano. Stavolta, però, facciamo un’eccezione perchè il libro recensito tocca un argomento di interesse generale, quello del testamento biologico e dell’eutanasia. Una questione tornata di grande attualità soprattutto dopo l’approvazione in Senato delle discusse norme che non riconoscono la libertà di scelta del paziente e impediscono di opporsi all’alimentazione e all’idratazione forzata. Il libro di cui parliamo è Accabadora di Michela Murgia. Lo ha letto per noi Antonietta Milone.
Di solito non ci occupiamo di argomenti che non siano catanesi e siciliani o legati comunque alla Sicilia e di interesse siciliano. Stavolta, però, facciamo un’eccezione perchè il libro recensito tocca un argomento di interesse generale, quello del testamento biologico e dell’eutanasia. Una questione tornata di grande attualità soprattutto dopo l’approvazione in Senato delle discusse norme che non riconoscono la libertà di scelta del paziente e impediscono di opporsi all’alimentazione e all’idratazione forzata. Il libro di cui parliamo è Accabadora di Michela Murgia. Lo ha letto per noi Antonietta Milone.
Era pensabile che a distanza di un anno dalle oscene polemiche che hanno accompagnato la morte di Eluana, si tentasse da parte di una giovane scrittrice sarda, Michela Murgia , un approccio a un problema che, non fosse altro per le lacerazioni che ha creato nel nostro Paese, sembrava aver inaridito alle fonti il pudore e la problematicità necessari per affrontarlo? Eppure l’autrice di Accabadora è riuscita in pieno a mantenere un mirabile equilibrio nel narrare una storia non così lontana nel tempo da poter essere tranquillamente rimossa o ignorata.
La protagonista del suo romanzo, Bonaria Urrai, è una donna che nonostante l’età avanzata e una vita trascorsa senza fisime, si lascia sorprendere da un tardivo desiderio di maternità e decide di prendersi in casa come fill’e anima una bimbetta di sei anni che ha la ventura di essere l’ultima di quattro figlie femmine e, per di più, orfana di padre.
Non era raro ancora negli anni ’50 che esistessero tali forme di baratto e che venissero persino giudicate socialmente accettabili: una promessa di eredità in cambio dell’accudimento fino alla morte dei genitori -in questo caso della madre adottiva- che si sarebbero fatti carico anche delle spese dell’educazione.
Il ritratto di questa strana madre, fisicamente, è inquietante: alta,severa,vestita di nero. Di mestiere, anche se benestante, fa la sarta ed è solita muoversi “rapida come un ragno femmina, tessendo intorno a quelle prede immobili una misteriosa ragnatela di misure”. Tuttavia, la familiarità con cui la bambina, Maria, prende possesso della casa, abituata com’era a considerare suo lo spazio della lunghezza d’un braccio, denota che il suo mondo interiore non viene affatto sconvolto.
Bonaria “si limitò ad aspettare che gli spazi rimasti vuoti per anni prendessero gradualmente la forma della bambina e, quando in capo a un mese, le porte delle stanze erano state tutte aperte per rimanere tali, ebbe la sensazione di non aver sbagliato a lasciar fare alla casa“. Affare ben diverso è lo sconcerto che sembra cogliere gli abitanti di Soreni, un piccolo paese della Sardegna, i quali sono al corrente di un’altra particolarità della donna, diciamo, una specie di carisma che richiede grande compassione e audacia rara. ”I silenzi si allungavano come ombre quando la vecchia e la bambina passavano per le vie insieme, suscitando code di discorsi a mezza voce sugli scanni del vicinato”.
La società descritta dai primi capitoli del romanzo è una società arcaica, volutamente immersa in una Sardegna immobile, le cui vicende sono scandite sui tempi lunghi dell’ antropologia. Usi e costumi hanno l’autorità che le generazioni che si sono succedute nell’isola hanno consacrati: la festa della vendemmia col suo alacre lavoro collettivo, cui dà il via l’assenso espresso da un saggio-beone dopo aver annusato prossimo nell’aria l’odore di mosto; la festa di fidanzamento in cui tutte le donne di casa si riuniscono a preparare gli amaretti e a far corteggio alla sorella maggiore, adorna dei doni del futuro sposo come una statua degli ex voto (“corallo in cambio di grazie, oro a peso a misurare la devozione”); più sontuoso ancora il laboratorio di pasticceria che si realizza alla vigilia delle nozze e impegna fino allo spasimo la famiglia per scolpire il pane nuziale da offrire a messa per l’offertorio, e tutte le altre leccornìe dai nomi e dai sapori antichi: gneffus, pirichittus, pabassinos.
In questo spaccato antropologico s’inserisce con altrettanta naturalezza la morte con le sue liturgie in cui armonicamente si fondono il pianto,la preghiera e la memoria in sequenza. Ogni volta che si levava il canto cupo dell’attittu, “era come se ai sorenesi venissero cantati i dolori di ogni casa, quelli presenti e quelli andati, perché il lutto di una famiglia risvegliava la memoria mai sopita di tutti i singoli pianti passati. Allora le ante delle finestre del vicinato venivano accostate, rendendo ciechi al sole gli occhi delle case, e ciascuno accorreva a piangere i propri morti nel morto presente per interposta assenza“. Si trattava di un codice essenziale alla comunità perché “anche il più controverso dei trapassi si riconciliasse con la naturale tragicità delle cose di ogni vita“.
Felicemente inattuale lo stile di tutto il romanzo, ma soprattutto di questa prima parte, dove il lettore si sente trasportato in una Sardegna mitica come la Sicilia vittoriniana di Conversazione, una regione resa in bianco e nero, i cui personaggi hanno movenze lente e austere, l’eloquio possiede un’aforistica asciuttezza, persino i corpi hanno una solidità degna di un Giotto.
Con tanta ieraticità contrastano i tempi più mossi e vibratili del romanzo di formazione di Maria. La quale, man mano che cresce, plasmata dalla mentalità della vecchia madre, comprende il valore della cultura, l’importanza di respingere da sé la menzogna e la dura lezione con cui l’ha appreso da Bonaria: “Ogni volta che apri bocca per parlare, ricòrdati che è con la parola che Dio ha creato il mondo“.
Ai suoi occhi la madre con la sua intransigenza morale e l’autorità indiscussa di cui gode nell’interpretare i tortuosi messaggi della superstizione, incarna un modello primitivo di giustizia che sa alternare in modo sicuro la grazia nel consolare chi è stato colpito da un lutto con le terribili maledizioni scagliate contro chi vorrebbe cinicamente piegarla a intervenire per propri fini “illeciti”. Però Maria, crescendo, riflette pure sulle misteriose uscite notturne della vecchia, sul fermo rifiuto che essa oppone alle sue domande infantili, “evanescenti come l’odore che si levava dalla cenere tiepida“, ripensa alla deferenza con cui la donna è stata accolta il giorno delle esequie nella casa dei Littorra dove a lei è avvenuto, osservando Santino, il figlio del morto, di riconoscere “le spalle ampie e la stessa controllata maniera di attendere che gli aveva visto la notte precedente“. Anche in un’altra circostanza sua madre era accorsa al capezzale di Tziu Jusepi Vargiu, presumibilmente per fargli un affumentu, ma Maria vi “pensò come dentro l’acqua, con la confusione sognante dei ricordi d’infanzia“.
Sempre nella sua vita i tempi della consapevolezza avevano avuto lo stesso andamento della risacca che puntualmente tiene dietro all’onda. Così, s’era trovata senza difese dinanzi alla rivelazione del suo più caro amico, Andrìa Bastìu, legato a lei da un tenace amore adolescenziale. Chi l’avrebbe detto che Nicola, il fratello di Andrìa, sarebbe diventato lo scoglio su cui sarebbe andata a infrangersi la vita di Bonaria Urrai? La sofferenza immedicabile del giovane dopo un incidente che gli era occorso nell’atto di vendicarsi in modo elementare di un’ingiustizia subìta, e la conseguente amputazione di una gamba gli avevano reso insopportabile vivere e gli avevano fatto prendere la decisione di implorare l’aiuto dell’accabadora, che fino ad allora “mai aveva avuto il dubbio di non esser capace di distinguere tra la pietà e il delitto“. Per la prima volta la vecchia aveva acconsentito a praticargli l’eutanasia attiva.
Oltre alla compassione che l’aveva sempre ispirata, il flash back ci illumina su un suo movente più intimo: da quando aveva venti anni essa aveva sempre portato dentro di sé il ricordo degli occhi brucianti di vita del suo ragazzo, morto in guerra nella trincea del Piave; anche lo sguardo di Nicola Bastìu, che ora si rivolge a lei “con la determinazione di chi cerca disperatamente non la pace, ma un complice” aveva la stessa luce di quegli occhi verdi “che frugavano nell’anima altrui come se non avessero paura del prezzo da pagare“.
Ma se Bonaria ha sempre attinto da una lunga frequentazione della morte le ragioni della sua responsabilità personale e sociale, senza mai mettere in discussione la sua parte di “ultima madre“, la presa di coscienza di Maria interviene drammaticamente a spezzare il legame che la unisce alla madre adottiva.
Nella piccola comunità di Soreni dove nascite e morti avvenivano in un clima di condivisa naturalezza, l’accabadora, moderna incarnazione della mitica Lachesi, si sentiva chiamata ad aiutare coloro che non riuscivano a spegnersi come una candela, come se fosse paradossalmente la “mammana”, chiamata a recidere il cordone ombelicale ai neonati. Ma questa volta, al suo rientro dalla casa dei Bastiu quel peso se lo sentiva addosso “come un manto bagnato” e la sua angoscia non poteva sfuggire agli occhi attenti della figlia, allorchè la scorse seduta accanto al “camino spento, raggomitolata nello scialle nero come un ragno intrappolato nella sua stessa rete“.
Il colloquio tra le due donne non lascia intravvedere alcuna conciliazione possibile: “Per me voi siete stata la prima (madre) e, se mi chiedeste di morire, io non sarei capace di uccidervi solo perché è quello che volete“. All’indomani Maria, raccolte poche cose in una valigia, se ne partì a Torino per guadagnarsi da vivere come bambinaia.
A una lettura superficiale i due capitoli dedicati al soggiorno torinese, potrebbero sembrare una digressione dal tema del romanzo, ma in realtà sono necessari sia a far decantare il rapporto tra madre e figlia, sia risultano funzionali al Bildungsroman di Maria. Il suo fragile amore per Piergiorgio, di pochi anni più piccolo di lei, ma soprattutto affidato dai genitori alle sue cure, la rende depositaria di un segreto inconfessabile dell’adolescente e le fa sperimentare sulla sua pelle l’autenticità del legame col ragazzo, nonostante tutte le apparenze contrarie.
Maria sarà licenziata su due piedi e apprenderà a sue spese l’impossibilità di giudicare dall’esterno il mistero di un sentimento che può nutrirsi solo di sussuri nell’ombra protettiva della notte. Di questo pudore la scrittrice si fa schermo sino alla fine, negandosi nell’ultimo straziante capitolo della morte dell’accabadora ad ogni giudizio morale, lasciando parlare al posto suo gli eventi, concatenati in modo che amore e morte vengano unificati dal loro essere entrambi un enigma inviolabile e un mistero in cui è impossibile penetrare.
Gli ultimi articoli - Cultura
Tornano su Argo i catanesinpalestina per parlarci della edizione 2024 del Nazra Palestine Short Film Festival
Le notizie che provengono da Gaza e dalla Cisgiordania sono sempre più drammatiche, oltre 42.000 morti,
Guidati ancora una volta dalla penna esuberante di Nino Bellia, scopriamo un originale artista che, da
La levata di scudi contro l’ipotesi di abbattere gli Archi della Marina dimostra quanto essi siano
La tutela dei beni culturali, e di quelli archeologici in particolare, è un argomento al quale