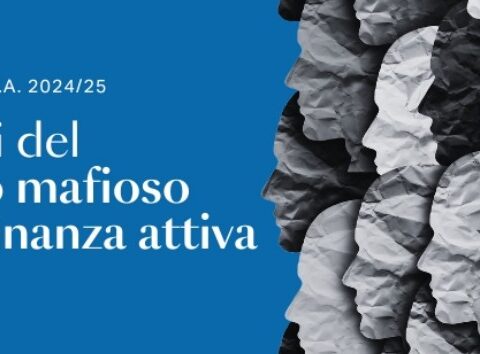Ospitiamo una riflessione dei Cobas di fronte ai ripetuti episodi di minacce e violenze nei confronti dei docenti, avvenuti a Catania, come in tante altre parti del Paese.
Alcuni giorni fa due docenti dell’Istituto scolastico Petrarca di Catania sono state aggredite dai genitori di un’alunna, una delle due è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. Non è il primo, né, purtroppo, sarà l’ultimo episodio. Certo, tutti hanno espresso solidarietà, le indagini e il processo attribuiranno responsabilità e saranno irrogate le dovute sanzioni.
Anche noi, ovviamente, esprimiamo piena solidarietà alle colleghe, ma pensiamo, visto che tali situazioni si ripetono continuamente, spesso senza arrivare agli onori della cronaca, che vada aperta una riflessione sul funzionamento della scuola. Senza dimenticare che, accanto alle deprecabili aggressioni fisiche, siamo ormai abituati a un esorbitante numero di procedimenti giudiziari contro i docenti di fronte a valutazioni degli alunni che le famiglie non ritengono congrue. In questo caso non c’è violenza fisica, ma, quasi sempre, si tratta di mezzi utilizzati come grimaldelli per fare pressioni e condizionare l’attività didattica.
Il ruolo sociale della scuola e degli insegnanti è oggi del tutto marginale, e di questo dovremmo discutere se si vuole invertire questo trend, evitando di ricorrere alla “militarizzazione” delle scuole. Recalcati chiede: “La pratica dell’insegnamento può accontentarsi di essere ridotta alla trasmissione di informazioni – o, come si preferisce dire, di competenze – o deve mantenere vivo il rapporto erotico del soggetto con il sapere”?
In premessa, sarà utile ricordare che, in spregio a tutte le normative europee, nella scuola italiana quasi un quarto dei lavoratori è precario (a tempo determinato), mentre un istituto scolastico su due è stato costruito negli anni sessata e settanta del secolo scorso, e la scuola a tempo pieno continua a essere un’eccezione nel Mezzogiorno.
Ancora, rispetto agli stipendi del personale, secondo il rapporto OECD (Education at a Glance 2024) l’Italia risulta il fanalino di coda dell’area Ocse. Infine, diversamente che nel passato, i nuovi docenti sono costretti a investire cifre significative per partecipare ai necessari corsi di abilitazione (pubblici e privati), propedeutici all’insegnamento.
In sostanza, scarsi investimenti (tranne un decisivo incremento con i fondi PNRR, ma si dovrebbe discutere sulla qualità di questi investimenti) e disinteresse diffuso. Tranne quando si chiede alla scuola, nelle attuali difficili condizioni in cui si trova, di risolvere i complessi problemi delle giovani generazioni, dall’educazione sentimentale alla lotta al femminicidio, dall’isolamento all’educazione stradale … O quando una lunga teoria di pseudo esperti si presenta quotidianamente nelle aule, sottraendo tempo prezioso al lavoro curricolare, per magnificare i diversi “prodotti”.
Ovviamente, il personale non è esente da colpe, in primo luogo quella di aver subito, quasi sempre, in silenzio le pseudo riforme che si sono succedute nel corso del tempo. Cambiamenti che dalla cosiddetta scuola dell’autonomia (centrosinistra) a oggi (destra-centro) non hanno incontrato soluzioni di continuità.
La scuola deve essere gestita come un’azienda, alunni e famiglie sono diventati clienti e, come diceva il governo nel 2013, occorre promuovere il capitale umano secondo la logica “dell’apprendimento permanente e del potenziamento del rapporto tra scuola ed esigenze di mercato”. Secondo Carosotti: “la centralità delle competenze rispetto alle conoscenze sta proprio in questo; si deve conoscere, con il minor sforzo possibile e in uno stato di ipotetica piacevolezza, solo ciò che serve a porci, sul piano dell’azione, nella capacità di rispondere efficacemente a richieste che ci provengono dal mondo esterno, quasi tutte da ambiti economici”.
E’ proprio questo insieme di politiche e di interventi che ha professionalmente indebolito la categoria docente privandola della sua identità. Nella scuola che verrà gli insegnanti diventano inutili. Per istruire gli allievi sulle nozioni essenziali, è sufficiente il variegato materiale presente in rete. Il futuro, almeno secondo gli orientamenti attuali, sarà caratterizzato dalla totale rinuncia alle potenzialità comunicative della relazione diretta, continuata e personale, legata al contempo a uno specifico disciplinare.
In queste condizioni “mantenere vivo il rapporto erotico del soggetto con il sapere” non sarà possibile. La comunicazione rimane, ma assume carattere ludico; il professionista si trasforma in organizzatore di laboratori, distaccato dalla disciplina d’insegnamento, la cui comunicazione è affidata a un altro strumento.
Se vogliamo contrastare tutto questo, e la conseguente degenerazione dell’ambiente scolastico, occorre pensare a una nuova formazione dei docenti, coerente con una scuola che è chiamata a non banalizzare problemi complessi, se vuole stimolare nella comunità studentesca lo spirito critico e la capacità di affrontare le questioni con autonomia di giudizio.
Una scuola che mette al centro il pieno sviluppo della persona umana, per far sì che l’individuo tiri fuori (ex-ducere) sia i suoi difetti per liberarsene, sia i suoi punti di forza per sfruttarli ai fini del suo miglioramento. Apprendere è un processo di “costruzione attiva” della conoscenza, nel dialogo e nella collaborazione con gli altri, con l’obiettivo di raggiungere quella capacità di riflettere e pensare in piena autonomia, cosa che solo l’educazione e non l’istruzione può dare.
Una riflessione che dovrebbe investire tutta la società, perché semplificazioni e tagli alla scuola non riguardano solo docenti e personale, ma parlano del futuro del nostro Paese.
Nino De Cristofaro – Cobas Scuola Catania