Plasmando nella creta, o tracciando nelle sue tele, i corpi contorti di figure umane dalle grandi mani e dai grandi piedi, Salvatore Incorpora esprimeva la fatica della vita, la sofferenza che egli stesso aveva vissuto e di cui ha lasciato testimonianza anche nelle pagine di diario raccolte nel volume “Quell’andare”, pubblicato a cura dei figli Gemma, Giovanni ed Egidio.
Di questo testo dall’intensità non comune ci parla oggi Marina Mangiameli, redattrice di Argo.
Tratto da una diario che emerge da uno dei momenti più tragici della storia europea, il testo, edito da Rubbettino, è uno dei più singolari e drammatici che mi sia capitato di conoscere.
E questo non solo per i contenuti, ovvero il racconto diretto dell’esperienza dell’autore in un lager nazista fra il settembre del ’43 e la liberazione nel ’45, ma per la forma stessa che, per un verso, rende il clima e la realtà che descrive quasi in modo plastico, presente, come se il freddo, il fango e la paura penetrassero improvvisamente sotto la pelle di chi legge, con la forza di un ricordo che, con poche forti pennellate, diviene immagine e traccia una storia angosciosa che mozza il fiato e oscura la vista.
La scelta dei curatori di lasciare gli appunti nella loro frammentaria discontinuità, senza nulla togliere al vigore del racconto, rende violentemente presente l’esperienza dell’autore che, per chi legge, tutt’al più, può evocare racconti di sopravvissuti o, più spesso, scene di film ma ci appare con violenza con tutti i suoi odori, rumori, penetra come l’umidità ed il freddo nei corpi dei deportati e scuote la coscienza.
Ma nella prosa un po’ sconnessa di Salvatore Incorpora divengono reali e presenti fatti situazioni, paure e speranze cui il ritmo spezzato della narrazione dà il senso dell’immediatezza, della precarietà.
Il passato ed il presente di dolore e d’angoscia si mescolano in un orizzonte in cui domina la consapevolezza di come sia assolutamente incomprensibile e insensato quello che succede eppure vero, presente, disperatamente inesorabile.
La strada fangosa, coperta di neve, lo stesso tedesco che alla fine di una giornata è “stanco” di colpire col calcio del fucile gli internati e poi i ricordi di un altro mondo “romantico”, del passato e della casa che sono spettri che insieme fanno male ma aiutano a sperare o almeno ad alleviare il dolore presente per un breve istante.
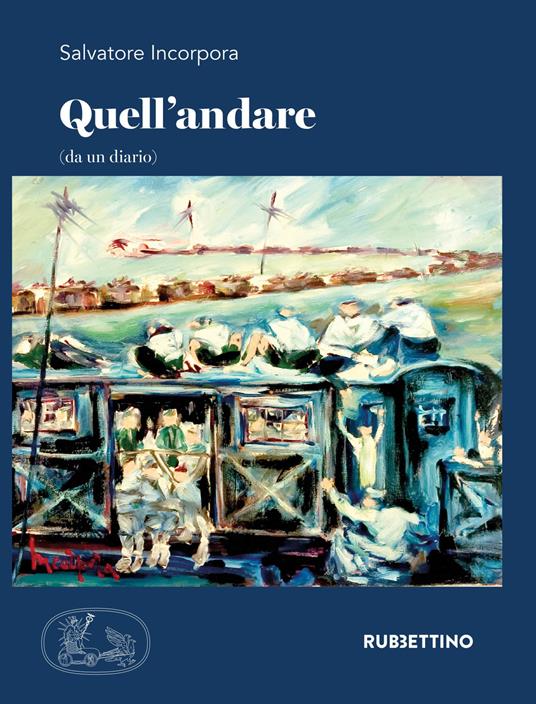
Un mondo dove non c’è spazio per la luce, la speranza, dove la stessa parola “domani” , se ci fosse ancora sufficiente forza per pronunziarla, fa paura. La disperazione si coagula nelle parole che descrivono non tanto il racconto ma le singole azioni, il peso, il loro suono. La neve che si incastra sotto gli zoccoli di legno, e che in qualche modo bisogna pulire per poter camminare, il carro che s’infossa lungo la strada e provoca i pesanti colpi di legno che piovono alla cieca sui prigionieri, ed il “sudore che si fa fango” ed i piedi avvolti in stracci bagnati ed il mesto incrociarsi di file di ombre che giorno o notte, Natale o Pasqua si incontrano sulla via che porta alla fabbrica.
C’è una forte materialità in tutto il racconto e si finisce per intuire che anche la frammentarietà non deriva da una “scelta” stilistica ma è anch’essa un elemento del racconto che è ritmato sulla vita del lager ed in qualche modo ne testimonia la brutalità. Poi, nella fabbrica è quasi tangibile il puzzo ed il peso del metallo fuso che cola negli stampi e che non dà alcuna gioia, alcun orgoglio dell’opera compiuta, solo la conferma che per il momento si è ancora vivi.
Nè si può sperare di comunicare a casa ciò che si sta vivendo perché nelle rare occasioni in cui si può scrivere è limitato lo spazio e soprattutto è sottoposto ad una rigida normativa ciò che si può o non si può dire ed è assolutamente escluso che si possa riferire nessun aspetto della condizione di cui si è testimoni e vittime.
Eppure ci si attacca alla vita, a Natale si fanno pastori per un improbabile presepe più che una concreta attività lo sforzo di recuperare un ricordo che testimoni un’altra vita, un altro mondo che è stato possibile e forse lo sarà di nuovo.
Articoli correlati su argo.catania.it
Ed infine il ritorno a casa in una sorta di incredulità crescente che porta a scoprire che oltre la notte, quella notte che sembrava infinita, c’è ancora un mondo pulsante, c’è un’alba possibile.
La guerra è finita, Hitler non c’è più, Mussolini penzola a testa in giù da qualche parte ed anche se la via del ritorno è lastricata di cadaveri, di morenti e di rovine quando si sente una risata, incredibilmente, sa di gioia.
Si ritorna a casa, senza sapone per lavarsi o pane da mangiare, senza certezza di come, quando e soprattutto se il treno su cui, fortunosamente, si è riusciti a salire partirà. E così, lentamente, tappa dopo tappa ci si allontana dall’orrore fino a giungere a casa ed è solo quel grido “E’ tornato!” che preannuncia alla madre il concretizzarsi della più insperata gioia che, nella cucina deserta di pane, nel focolare senza fuoco dove arde solo la miseria, porta una speranza nuova, una luce calda e forte.
In quest’epoca di “effetti speciali” e colossal cinematografici questo libro è, per molti motivi, una testimonianza preziosa.










